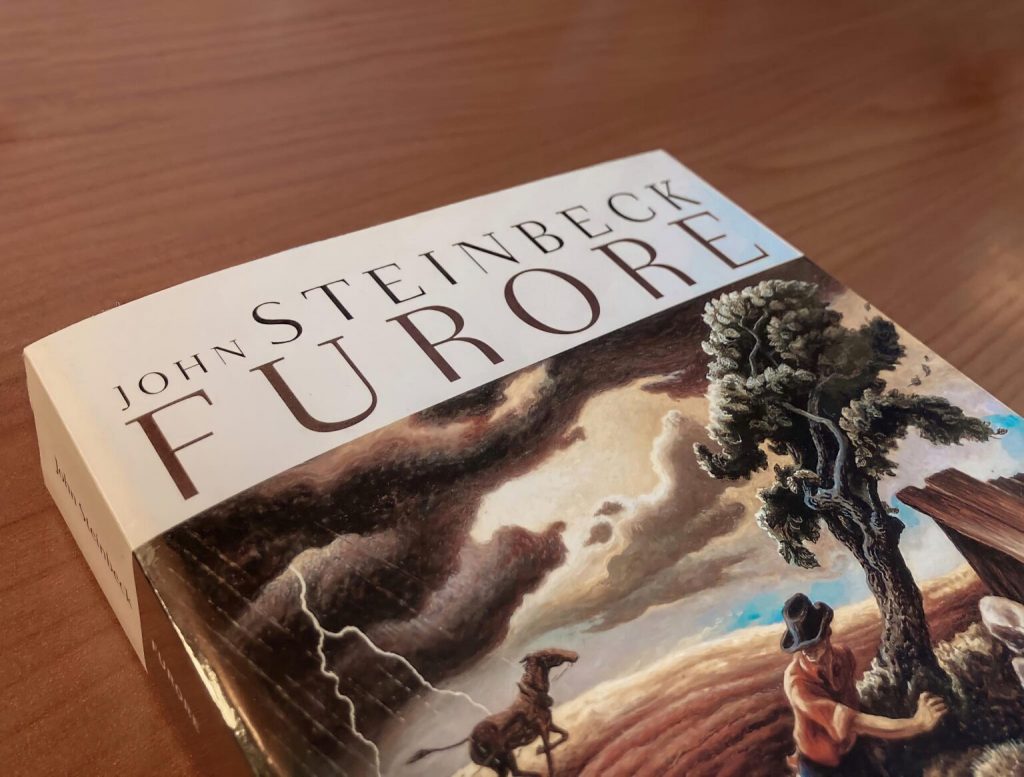La letteratura contemporanea comincia con Odisseo che peregrina per anni in cerca della sua Itaca in cui farvi ritorno. Ma – tutto sommato – solo per ripartire, ri-abbandonandola. Dal peregrinaggio al pellegrinaggio. Dall’erranza al viaggiare in terra straniera. Da forestieri. Qualcuno che viene da fuori. Ogni generazione porta con sé una forma nuova di migrazione. E molti scrittori hanno cercato di raccontare l’epopea dei migranti. Qualcuno è persino stato in grado di rendere epiche le loro gesta estreme.
John Steinbeck (1902 – 1968) ha scritto – senza dubbio – le pagine più belle e intense di tutta la storia della letteratura. The Grapes of Wrath. Tradotto in italiano con ‘Furore’. ‘Acini di rabbia’ – la traduzione letterale – era un titolo forse troppo poetico. Forse poco incisivo sul piano comunicativo. ‘Furore’ è sintesi, baleno, squarcio. Inchioda il lettore al muro della storia narrata: le conseguenze antropologiche e sociali della ‘Grande Depressione’ del 1929.
Ma gli ‘acini di rabbia’ sono il filo rosso che unisce ogni parola della storia raccontata: sono acini di rabbia i protagonisti; acini di rabbia i giorni che si susseguono tra speranza e catastrofe; acini di rabbia sono i luoghi assolati di giorno e umidi di notte; acini di rabbia gli animali che s’incontrano lungo il cammino. Il mosto che esce dalla spremitura di questi acini è una storia che assume una valenza universale – quindi ancestrale e futuribile -, scritta e pubblicata nel 1939, ma contemporanea del mare solcato da Odisseo così come a quello dei migranti che si schiantano sugli scogli di Lampedusa, nel cuore del nostro mare Mediterraneo.
Allora, come oggi, c’è sempre qualcuno che fugge dai morsi della fame, dal teatro della guerra, per avere scelto – non soltanto – di non morire, ma anche – e soprattutto – di non ammazzare nessuno. Si parte. Con qualsiasi mezzo. Nella storia raccontata da Steinbeck i protagonisti – la famiglia Joad – “si vogliono comprare una macchina per andarsene all’Ovest, che lì si campa meglio”. L’Ovest diventa sinonimo di speranza, di garanzia di salvezza.
L’Ovest narrato in ‘Furore’ segue la ‘Route 66’, che “è la principale strada migratoria. […] La 66 è il sentiero di un popolo in fuga, di chi scappa dalla polvere e dal rattrappirsi delle campagne, dal tuono dei trattori e dal rattrappirsi della proprietà, dalla lenta invasione del deserto verso il Nord, dai turbinosi venti che arrivano ululando dal Texas, dalle inondazioni che non portano ricchezza alla terra e la depredano di ogni ricchezza residua. […] La 66 è la strada madre, la strada della fuga”.
La strada come un grande fiume che scorre verso il mare dell’Ovest. Solo che le migrazioni si trascinano dietro ogni tipo di problemi. Il più grande di tutti sono le prime avvisaglie che la Terra Promessa – a mano a mano che le si avvicina – sembra non essere più in grado di mantenerla – la promessa. Quando uno sciame di umanità che migra incontra l’alveare che lo dovrebbe ospitare produce un cozzo, un impatto cruento: sono gli effetti collaterali di chi varca una frontiera, quella terra di nessuno in cui ci si guarda fronte e fronte, in attesa che qualcuno compia una mossa, faccia un passo, d’avanzata o di ritirata. L’uomo non rinuncia alla trascendenza, al vagheggiamento di mondi migliori, a credere che la bussola della speranza indichi sempre un Ovest da raggiungere, per cancellare gli orrori del collasso di un quotidiano che diventa cappio intorno al collo di chi non ha il coraggio di mettersi in marcia.
Intanto, il tempo della transumanza umana, della carovana dei disperati che si mette in cerca della terra guarente i loro mali, crea una comunità che si rinsalda proprio per il fatto di essere dei diseredati di massa dal mondo: “si raccoglievano insieme; parlavano insieme; mettevano in comune le loro vite, il loro cibo, e le cose che speravano di trovare nella nuova terra”. Sono i primi benefici effetti dello sperare collettivamente, una forza in grado di spazzare via i malesseri e i tormenti e le disperazioni degli stenti affrontati e da affrontare, e addirittura in grado di produrre un simulacro di felicità, un’anticipazione del paradiso terrestre, del premio che sarà riconosciuto a chi con ostinazione lotta per conquistare quanto desiderato.
La storia raccontata da Steinbeck prosegue nei dettagli delle singole vite. Uno dei protagonisti – Tom Joad – si ritrova ancora costretto a uccidere, sempre per legittima difesa, in difesa del suo amico predicatore – Casy. È una storia amara. Di una lotta che non finisce. Come di uno sfruttamento che non finisce. I migranti sono diventati i nuovi schiavi nei campi di cotone. E se il libro si apre con una polvere che ricopre ogni cosa, che spinge una popolazione a migrare all’Ovest, il libro si chiude con un Ovest ricoperto di nuvole grigie giunte dall’Oceano, che si trasformano in pioggia che per due giorni irrora la terra riarsa. Che diventa pozza. Poi lago. Poi la putredine della palude. Fango che s’insinua ovunque. Pioggia che martella senza tregua. Uomini donne e bambini rannicchiati sotto una tettoia.
4444L’uomo è un animale sociale che si rafforza anche dei propri sogni. Delle proprie utopie. L’Ovest dell’immaginario, gli Eldorado agognati dagli oppressi, servono a cementare le relazioni, a sentirsi parte di qualcosa di più grande del sé: “Se due cadono, uno aiuta l’altro a alzarsi”.
E quando lo stesso Tom constata di essere acquattato tra i rovi, per sfuggire a una probabile sua cattura, quindi nella stessa condizione del deserto predicato da Casy, giunge a pronunciare una memorabile orazione, manifesto degli oppressi contro tutti gli oppressori – e contro tutte le ingiustizie -: “Perché io ci sarò sempre, nascosto e dappertutto. Sarò in tutti i posti… dappertutto dove ti giri a guardare. Dove c’è qualcuno che lotta per dare da mangiare a chi a fame, io sarò lì. Dove c’è uno sbirro che picchia qualcuno, io sarò lì. Se Casy aveva ragione, be’, io sarò negli urli di quelli che si ribellano…e sarò nelle risate dei bambini quando hanno fame e sanno e sanno che la minestra è pronta. E quando la nostra gente mangerà le cose che ha coltivato e vivrà nelle case che ha costruito… be’, io sarò lì”.
Lì è proprio quell’Ovest dove anche noi – purtroppo – non siamo ancora giunti. Ma che possiamo immaginare, desiderare, costruire insieme, magari cominciando proprio da una lettura solitaria, su una spiaggia assolata, all’ombra di un ombrellone, tra un tuffo e un morso di piadina.
Paolo Vachino