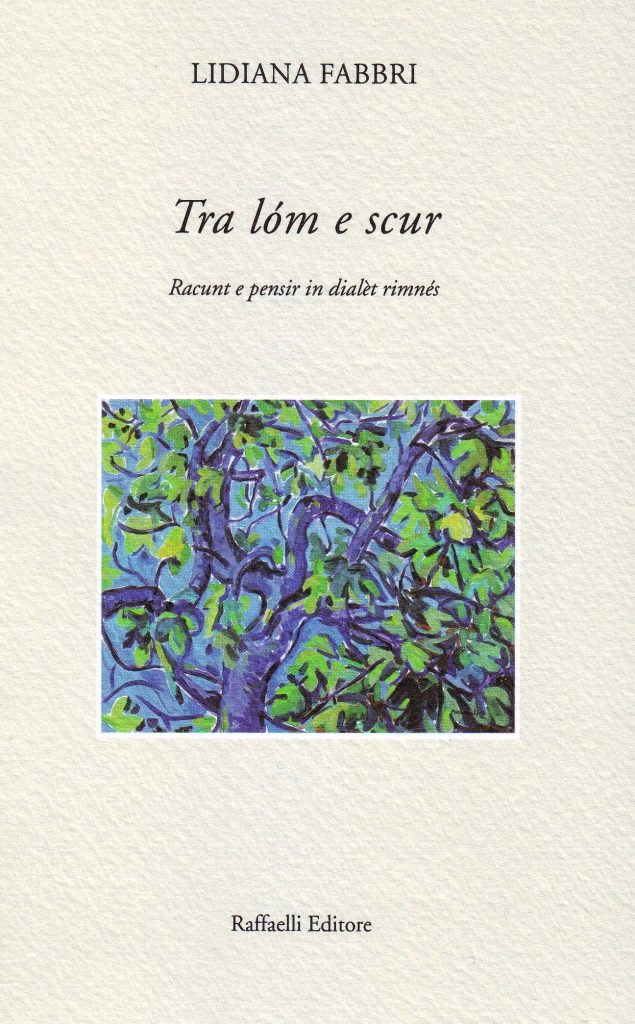Lidiana Fabbri: “Tra lòm e scur” – Panozzo.
Sono passati ormai oltre quindici anni dal mio primo incontro con Lidiana. Tredici da quando l’aiutai ad editare la sua prima raccolta, “S’un fil ad vènt” (Comune di Coriano, 2007), e nella mia postfazione terminavo augurandomi che Lidiana continuasse “a ‘cantare’ e a regalarci nuove emozioni”.
L’ha fatto l’ultima volta con “Mulìghi” [Briciole] (Il Ponte Vecchio, 2016), la sua quarta pubblicazione. Dove si comprendeva che si stava avviando verso una piena maturità artistica, tanto che in questo suo quinto libro sembra raggiungere un nuovo traguardo importante del suo personale percorso poetico. In questi anni Lidiana ha fatto molta strada per riuscire a raccontarci la sua visione del mondo che, partita dai ricordi degli anziani di Cerasolo, suo borgo natio, l’ha poi portata ad affrontare temi “caldi”, come la consapevolezza femminile, la condanna di ogni violenza, la speranza per il futuro dei giovani.
In questa nuova opera Lidiana compie un ulteriore passo: chiede di impegnarci a leggere i suoi testi in dialetto, privi della traduzione in italiano. Le strofe – dice – mi nascono “direttamente in dialetto, non ho mai scritto in italiano e tradotto poi in dialetto”. “Il libro è nudo, oserei dire, ma anche autentico: vorrebbe essere un inno al dialetto. Ho lasciato che la mano scorresse libera, senza ostacoli e costrizioni, senza orpelli. Non nascondo la soddisfazione di essere stata così libera in questa decisione”.
Questa libertà acquisita la si avverte leggendo i sette racconti e le nuove poesie. C’è come una consapevolezza ormai certa delle proprie capacità espressive. Ma anche una maturità linguistica, frutto certamente degli studi che Lidiana in questi anni ha fatto della produzione poetica degli altri autori dialettali romagnoli oltre che delle modalità di scrittura del dialetto.
Dopo una vita di lavoro, attorno ai cinquant’anni, per Lidiana s’è posta la necessità di tornare ad esprimersi in dialetto: “E’ la prima lingua che ho ascoltato, in famiglia si parlava in dialetto, come nei mercati, nelle osterie, nei campi. Dovetti abbandonare questa mia prima lingua: specialmente a scuola era proibito anche dire una sola parola in dialetto”. “Non so come, dopo alcuni decenni questo dialetto ribolliva in me (…) finché, nella lingua che mi è cara, cominciarono a nascere i primi scritti dialettali”.
L’ultima poesia del libro potrebbe essere tranquillamente un invito a sperare, a credere nel potere delle parole anche nei momenti più bui come potrebbero essere quelli che stiamo vivendo in queste settimane in cui il mondo è sconvolto da questo virus che ci paralizza:
“Quando e’ cor / e fa pió mèl / la penna la sémna / pió paroli …”
Parole buone, di speranza, il credere in un futuro positivo: come quelle di Papa Francesco, del Presidente Mattarella. Non certo le parole di mestatori d’odio.
E Lidiana nel libro compie poi un’operazione straordinaria: traduce in dialetto romagnolo i pensieri di Hetty Hillesum (1914-1943), scrittrice olandese ebrea vittima della violenza nazista e morta in un campo di concentramento: “Andemma po’ aventi, e’ zà, cum’è c’a pos scriv i turment dla mi àlma, stretta e gricida dèntra un stupid foj ad chérta sal righi blò?”.
“Us dis che in Germania i splèss viv ma i’ Ebrei, i’i fa murì se’ gas, quanti stori. Al sarà vérra, al per folli. Al strèdi a gl’i è sempre pió svuidi”. “Quand sta’ cativeria l’à sarà fnida u i sarà qualcun che i farà cnòss i fat at sta’ guera, u i sarà qualcun che scriverà la storia pricisa”.
Sono splendidi i due testi di apertura: “La vòsa dla chésa” e “Paroli te’ vènt”. Nel primo testo Gino, Tonino, Flora, Maria, Vincenza, Aldo, Giorgio, Pietro, Ubaldo, Pasquale, Vito, Rosa ed altri raccontano la loro solitudine, “i’è arvenza daparsé”. “Un gnè pió e tèmp da pasè si’ nost vécc / la misiria la è finìda / an avém e’ tèmp da ciacarè / òz e’ per cù i séa una misiria nòva. // A’ sem purétt ad paroli / queli da dì / purétt ad paroli / quelli da stè da santì …”.
Nel secondo testo prende la parola una donna disperata, moglie o figlia, verso un uomo che ormai ha perso la sua battaglia con la bottiglia. “Vin a chésa t’e cà bivù una ma-sa”. “An voi che ch’i élt it vegga isé”. “Nu’ fàm piégn énca òz, tè t’am fè stè in pensir”. “La-sa che’ bicir se an sbai quest l’e e’ terz / lasli se’ tavulèin ut fa mèl”. “An ti voi veda isè, ades a telefon me’ tu fiùl / e a voi veda se ma lò t’a i dè retta”. “La-sa che bicir nu’ fàm vargugnè daventi ma’ tótt / andémma a chésa”. “Per piàser … ormai a nò più e’ fiè … vin a chésa … per piàser …”.
Il tema dell’alcolismo Lidiana lo riprende anche in una poesia: “E vèin”.
“A’ so’ arvènza scòta / quand a’ s’èra burdèla / a’ véda qualdùn dla mi’ chésa / cl’alzèva la vósa / e dvantèva cativ senza mutiv. // Ĕnca qualdùn dèntra tl’cantèina / che biviva un fiàsch pin / e dvantèva ròss tla fàza / e l’aviva una ciacarèina. // Adés um fa pavura e’ vein / snò a santil a’ numinè … “.
E poi ancora un testo, “L’udór dla nìva”, dove le donne attendono per la festa di Natale il rientro del marito e del padre dall’estero, dove è andato a lavorare: “E’ bà l’èra migrent tla Svézra, se’ zèi. Da nùn e’ lavor l’era poc”. “E’ bà l’era arvàt, al campèni al suneva per clamè d’andè la messa”. “I vsèin i dèva da’ di me’ bà, il salutèva, la mà, la’l tniva a bracèt, tòt insen”. “La nìva la pareva ad zócri, l’aviva un udor particuler, énca lia che’ dè …”.
“In questo nuovo volume sono racchiusi brevi racconti scritti nel corso degli anni, storie semplici di fantasia. Tutti hanno avuto riconoscimenti in concorsi letterari dialettali”. “E’ un libro pensato e scritto in cucina, il luogo che mi è più congeniale, specialmente durante gli inverni. Forse è proprio nell’atmosfera ‘tra lóm e scur’ che i pensieri vengono in mente”.
Lidiana si domanda in quanti leggeranno questo libro, “perché il dialetto può apparire difficile sia da leggere, sia da comprendere”. Vero, ma i messaggi che i testi di Lidiana contengono sono universali, belli, buoni. E questo penso sia una scusa più che accettabile per sforzarsi di leggere e comprendere parole che non sono una ostica lingua straniera, ma un pezzo del nostro recente passato, il dialetto, che ancora manteniamo nel nostro DNA, anche se forse non lo sappiamo.
Paolo Zaghini