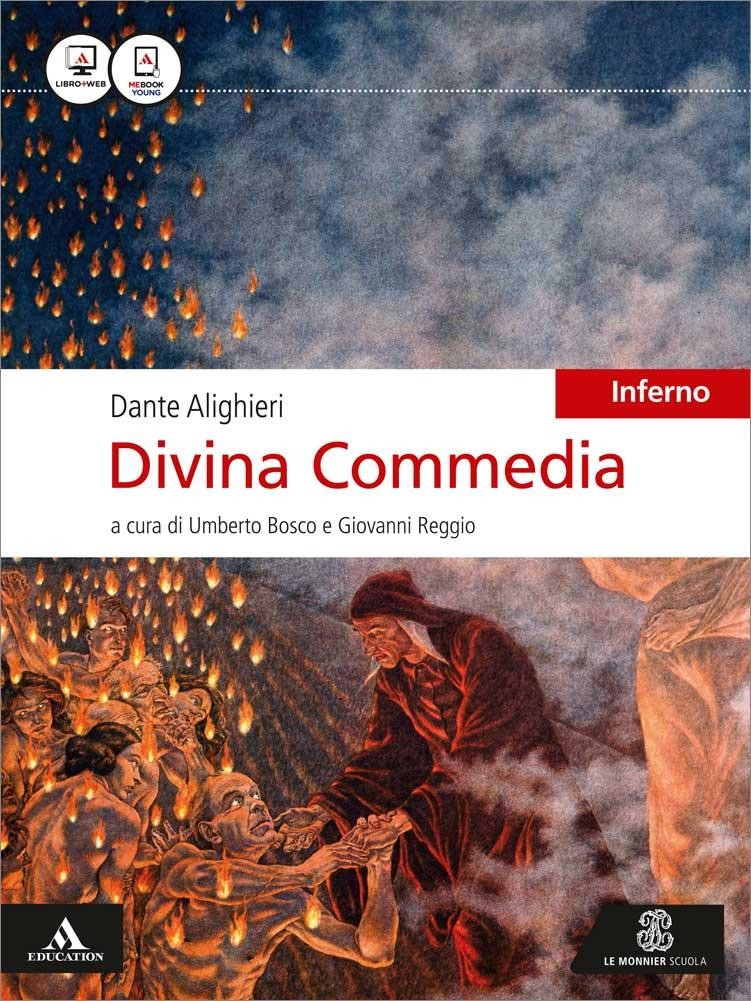Questa è l’estate giusta per portarsi sotto l’ombrellone Dante Alighieri. Innanzitutto per omaggiare l’anniversario del settecentesimo anno dalla sua morte. E poi perché il clima torrido ricorda quello delle bolge infernali.
Ed è proprio la prima cantica dedicata all’Inferno che dovete mettere subito in borsa. Edizione Le Monnier a cura di Umberto Bosco e Giovanni Reggio. Peso: 426 grammi. Sopportabili se si pensa che per ogni grammo ci cono milioni di spunti di riflessione e di godimento estetico-poetico.
Noi italiani parliamo – dopo settecento anni – la lingua inventata da questo toscano inquieto e geniale. La Divina Commedia è la sfida più alta che l’uomo abbia mai innescato tra la vita e l’arte. Il magistero di Dante consiste in questo: arte e vita sono sinonimi. E siccome vivere è attraversare l’inferno della precarietà e dell’insensatezza, Dante crea un pezzo di mondo che non è solo letteratura. È entrare nella pancia stessa dell’umano. Non solo di quella individuale, ma nella vita di tutti.
Sfogliare le pagine dell’Inferno dantesco significa precipitare nel buio sottosuolo dell’umanità, dove il male ha prevalso sul bene e non per questo si deve voltare lo sguardo altrove e ignorare. I condannati non possono urlare altro che la (loro) verità. E questo urlo spaventa tutti. Perché il bagliore della verità che fende il buio della colpa e del peccato può accecare, far perdere la vista e la via del pellegrino che ostinatamente non teme di addentrarsi nel cuore del mondo. E senza maestri non si va da alcuna parte. Senza un dolcissimo padre – come Virgilio per Dante -, che ci accompagni per il tratto più misterioso e impervio del viaggio, non si approda in alcun luogo.
L’Inferno, come ogni testo archetipico, può essere letto a discrezione del lettore. Saltabeccando in qua e in là in ordine assolutamente libero e sparso. Non c’è una trama da seguire. Ma un flusso al quale abbandonarsi. Dante anticipa la relatività einsteniana. In ogni canto – relativo rispetto al tutto – è racchiuso l’assoluto.
Nel canto di Paolo e Francesca c’è lo stesso ‘tutto’ contenuto nel canto del Conte Ugolino. Allora l’Inferno va letto con la stessa agilità dello scegliere uno stabilimento balneare in spiaggia a Rimini. Si comincia dal bagnino 25 e poi il giorno dopo si passa al bagno 10 e quello dopo ancora al 34. Diversi luoghi e prospettive ma la stessa sabbia e la stessa acqua salata.
Il mio consiglio è di partire dal canto – per me fodamentale – di tutta l’opera. Il canto XXVI. Dove il grande protagonista è Ulisse. L’ottava bolgia. Quella dei consiglieri fraudolenti o degli orditori di frodi. Dove dietro a una fiamma a due punte si nascondono Ulisse e Diomede. Ma è il primo dei due eroi greci a rispondere all’invocazione. Dal verso novanta al centoquarantadue è scritta la storia degli ultimi settecento anni, quanto meno. Ma in realtà di più: la storia dell’intero genere umano.
Un verso recita “[…] ma misi me per l’alto mare aperto”. In ogni esistenza giunge il momento di mettersi per l’alto mare aperto, per fare esperienza del mondo e incontrare il valore e i vizi dell’umano. Ma il verso comincia con un ‘ma’. Una preposizione avversativa. A che cosa avversa? Ecco Dante: “né dolcezza di figlio, né la pietà / del vecchio padre, né ’l debito amore / lo qual dovea Penelopè far lieta, / vincer potero dentro a me l’ardore / ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto / e de li vizi umani e del valore”. La recisione del cordone ombelicale degli affetti. Si parte sempre soli. O in compagnia di una piccola comunità.
Dante prosegue il racconto, infatti, con la famosa orazion picciola. Ulisse che vuole convincere i compagni che occorre varcare le Colonne d’Ercole del notum – le nostre conoscenze e certezze – per entrare nel mare alto e periglioso del novum, di ciò che non conosciamo ma da cui ci sentiamo visceralmente attratti. Spingersi oltre il limite indicato dalle convenienze alla ricerca del confine ultimo di ogni sé. E se i compagni vengono appellati come frati, cioè fratelli, a far detonare le loro coscienze è il famossimo distico: “fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e canoscenza”.
Suona forte un altro ‘ma’, a inizio verso, ma questa volta vuole essere tagliente come una ghigliottina. Non siete bestie violente e disumane; occorre seguire la virtù e la conoscenza per accedere al grado sommo dell’umano. Tutto molto bello e soprattutto molto giusto. Peccato che in quell’invocazione si annidi il germe della disuguaglianza, aprendo una strada che – nell’estreme conseguenze – porta dritto alle dittature. Perché fatti non foste? E non fatti non fummo?
Solo la prima persona plurale è legittimata a incarnare la fratellanza e la fraternità. E non è un caso che proprio la fraternità sia lo spirito mancante del nostro tempo. La libertà e l’uguaglianza possono essere disciplinate nelle costituzioni e nelle leggi. La fraternità, invece, non è un diritto che si acquisisce ma un dovere non imponibile da qualsivoglia governo o potere costituito. Sgorga dalla cellule. Scorre nel sangue. Nel pensiero commosso e partecipato.
Ulisse, invece, si chiama fuori da quel noi. Arbitrariamente. Volutamente. L’arte occulta del persuasore, che mentre esorta e seduce – allo stesso tempo inganna. Nessuno può sentirsi non convocato da quell’impronunciato ‘fatti non fummo’. Il noi è l’imbuto in cui l’umanità versa la sua essenza comunitaria. Diffidare da chi si proclama fratello e poi appella i proclamati fratelli con il ‘voi’.
Per cui, portarsi Dante sotto l’ombrellone è portarsi una crema potentissima contro le ustioni dell’anima causate dagli oppressori mascherati da solidali. In ogni terzina è racchiusa una fetta di mondo che ci riguarda perché ogni genio è ovviamente anhe un profeta. Dante è raggio solare che scotta e allo stesso tempo unguento protettivo che allevia. Da questa lettura, che va fatta in maniera antiscolastica, anarchica, libera e ribelle, si esce tonificati come dopo una giornata di sole e un bagno rinfrescante nell’acqua salata. Buona seconda lettura estiva.
Paolo Vachino