La presentazione del volume “Storia del PCI in Emilia-Romagna. Welfare, lavoro, cultura, autonomie (1945-1991)” a cura di Carlo De Maria (Bologna University Press, 2022) avverrà sabato 3 dicembre, presso la Sala del Buonarrivo della Provincia di Rimini in Corso d’Augusto, alle 16.30. De Maria che avrà come suoi interlocutori Giuseppe Chicchi, Sergio Gambini ed Emma Petitti.
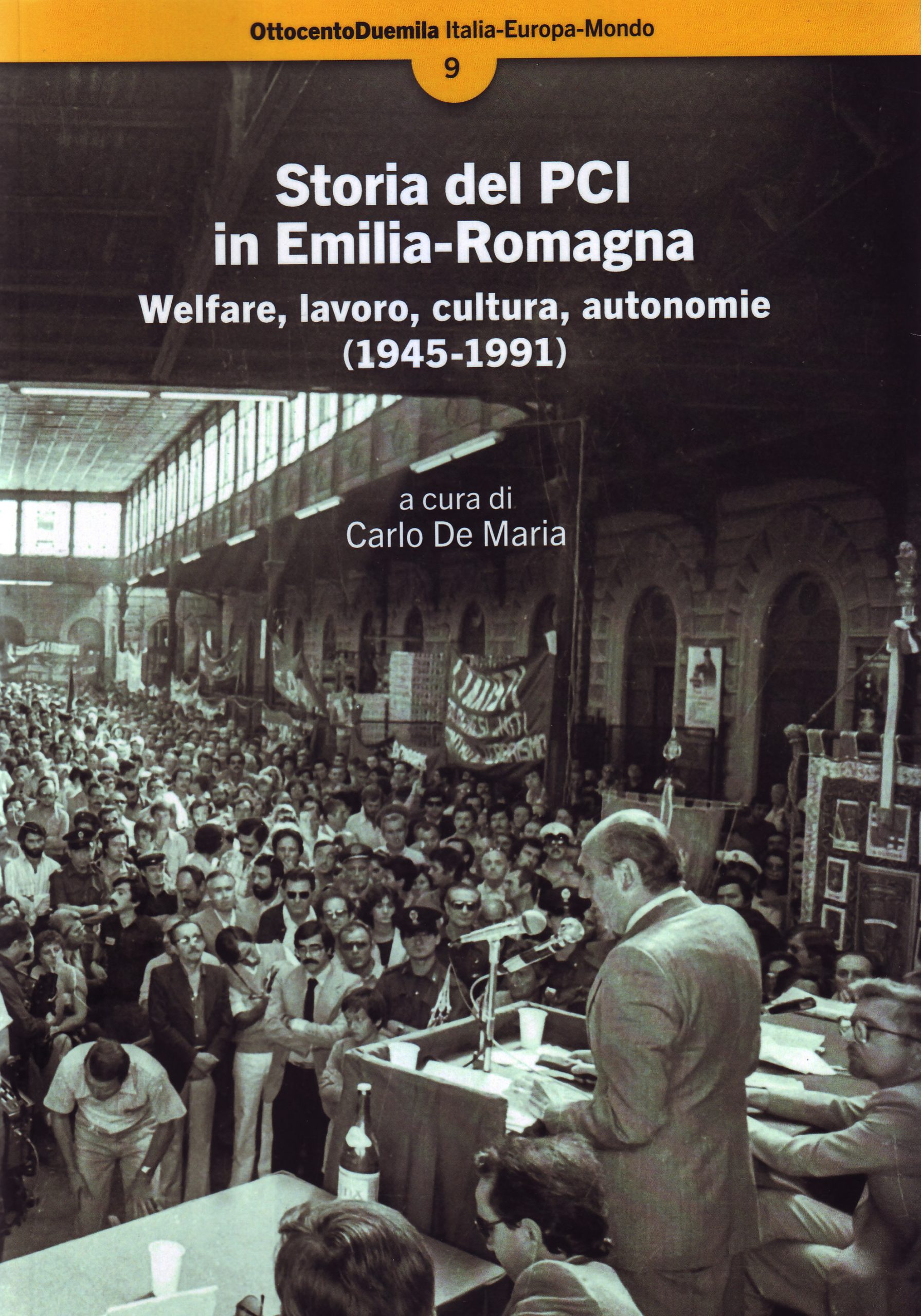 Carlo De Maria è professore associato di Storia Contemporanea presso l’Università di Bologna, ed è il curatore delle tante iniziative messe in campo per il centenario della nascita del Partito Comunista Italiano nella nostra Regione dalla rete delle Fondazioni democratiche in collaborazione con la rete degli Istituti storici della Resistenza, dell’Istituto Gramsci e dell’UDI.
Carlo De Maria è professore associato di Storia Contemporanea presso l’Università di Bologna, ed è il curatore delle tante iniziative messe in campo per il centenario della nascita del Partito Comunista Italiano nella nostra Regione dalla rete delle Fondazioni democratiche in collaborazione con la rete degli Istituti storici della Resistenza, dell’Istituto Gramsci e dell’UDI.
A Lui abbiamo fatto tre domande che anticipano i temi che saranno trattati nell’incontro di sabato.
Nel libro si sostiene che il Partito comunista in Emilia-Romagna costruì un’esperienza di governo riformista, una sorta di “socialdemocrazia locale”. Che cosa significa?
“Con i ricercatori che hanno collaborato come me nella realizzazione di questo volume ci siamo chiesti quali siano stati in Italia, nella seconda metà del Novecento, le esperienze politiche concrete più significative nella direzione di una conciliazione tra sviluppo capitalistico e giustizia sociale. In altre parole, chi perseguì concretamente un progetto socialdemocratico?”.
“Una delle esperienze di amministrazione e governo del territorio più significative da questo punto di vista è quella fornita dal Partito comunista in Emilia-Romagna tra gli anni Sessanta e Ottanta. Il riferimento è volutamente al Pci emiliano-romagnolo, che rispetto al partito nazionale esprimeva peculiarità molto nette in materia di valorizzazione delle autonomie, di riflessione sulla forma-partito e di attitudine riformista.
Quello che era in origine, nel 1921, un piccolo partito di rivoluzionari, passato negli anni Venti e Trenta attraverso la lotta clandestina e l’esilio antifascista, si dimostra capace di trasformarsi, dopo la Seconda guerra mondiale e la Resistenza, in un grande partito di massa. Lo strutturarsi del Pci in partito di massa e, in Emilia-Romagna, in partito alla guida degli enti locali, rappresenta il punto di partenza della nostra riflessione. È a partire dal 1945, infatti, che si apre nella storia del Partito comunista un ventaglio di temi decisivi, propri di un grande partito popolare: dal governo del territorio alla costruzione del welfare, dai problemi del lavoro e dello sviluppo economico all’organizzazione della cultura”.
“Se ancora nel dopoguerra il Pci aveva un bagaglio culturale ben diverso dal riformismo – e qui deve essere richiamata naturalmente la storia di un partito che affondava le sue radici in un passato rivoluzionario e leninista, la cui cultura politica era stata pesantemente condizionata, anche in Italia, dalla concezione staliniana della «socialdemocrazia» come «socialfascismo» (termine usato dall’Internazionale comunista tra anni Venti e Trenta che equiparava socialdemocrazia e fascismo), un partito che per lungo tempo, fino al passaggio tra anni Sessanta e Settanta, risentì dell’influenza sovietica –, resta il fatto che in Emilia-Romagna i limiti del vecchio ‘bagaglio’ comunista furono superati meglio che altrove aprendo la via, di fatto, a un modello di sviluppo socialdemocratico e riformista”.

Carlo De Maria
Quale fu il periodo migliore di questo modello riformista emiliano-romagnolo?
“Il Pci in Emilia-Romagna visse il suo momento più intenso, dal punto di vista progettuale, in corrispondenza del regionalismo dei primi anni Settanta. Non è un caso che l’espressione «modello emiliano-romagnolo» entri pienamente nel dibattito pubblico proprio allora”.
“Ma la spinta all’innovazione e alla sperimentazione proveniva dal decennio precedente. All’inizio degli anni Sessanta, di fronte all’avvento del centro-sinistra al governo del paese, si registrò una cauta apertura verso la nuova formula di governo da parte di Palmiro Togliatti, che era nell’ultimo periodo della sua leadership e che delineò per il Pci una opposizione di tipo particolare, volta a tallonare la nuova maggioranza nata dall’incontro tra Dc e Psi, sfidandola a realizzare le riforme promesse e al tempo stesso rafforzando l’elaborazione programmatica dei comunisti. In quello stesso periodo, nel quadro delle scelte nazionali operate da Togliatti, l’iniziativa politico-amministrativa dei comunisti in Emilia-Romagna venne a porsi in termini esplicitamente competitivi rispetto al centro-sinistra”.
“Il Pci emiliano-romagnolo assumeva allora una «funzione nazionale», con riferimento alla linea delle «anticipazioni» rispetto alle politiche governative: le amministrazioni «rosse», nei vari settori di intervento degli enti locali, cercarono di assumere un ruolo anticipatore per precorrere, promuovere e, contemporaneamente, influenzare le riforme nazionali. Una prospettiva di governo, dapprima municipale e poi regionale (nel 1970, la nascita della Regione aprì a sua volta la strada a nuove esperienze di governo del territorio), che esprimeva lo sforzo di affrontare, tramite le politiche pubbliche, le problematiche poste dallo sviluppo economico: una distesa politica riformista, capace di entrare in consonanza con l’esperienza socialdemocratica europea”.
“Andava delineandosi una sorta di socialdemocrazia locale, dove l’attore principale non era lo Stato, come nel modello socialdemocratico classico, ma il sistema delle autonomie. Era un’idea di socialdemocrazia anti-centralistica, che puntava sulle autonomie locali, sulla piccola e media impresa industriale, sull’artigianato industriale e di servizio, sulla cooperazione”.

Da sinistra, Giorgio Tonelli e Carlo De Maria
Per quali ragioni si esaurì questa esperienza? E quali prospettive ha oggi la sinistra?
“Dal punto di vista politico la crisi iniziò con i governi di «solidarietà nazionale». Alle elezioni politiche del giugno 1976 il Pci raggiunse il più alto consenso elettorale della sua storia. Poche settimane dopo, alla fine di luglio, prendeva avvio l’esperienza dei governi di «solidarietà nazionale» con il terzo governo Andreotti che superò la votazione di fiducia in parlamento attraverso l’astensione del Pci. La fortissima tensione al cambiamento che aveva caratterizzato il partito non trovava più appigli di fronte a un governo di consociazione. Il Pci aveva raccolto un largo consenso, anche fra le fasce giovanili, proprio per la sua identità di partito alternativo alla vecchia classe dirigente, in grado di portare un «vento di cambiamento» all’interno delle istituzioni”.
“La partecipazione ai governi di «solidarietà nazionale» (1976-79) indebolì la spinta riformista del Pci e anche la sua immagine ‘alternativa’ rispetto al sistema di potere statale. Il partito diede indubbiamente un contributo nazionale decisivo nella difesa dello Stato contro l’emergenza del terrorismo. Per altri versi, però, il partito entrò in una crisi politica profonda. La ricentralizzazione nei processi decisionali e nelle politiche pubbliche che si manifestò in quegli anni penalizzò in maniera particolare l’attitudine riformista e autonomista del Pci emiliano-romagnolo”.
“Nel decennio successivo, gli anni Ottanta, si assistette in Italia al declino dell’idea stessa di programmazione, che era stata la vera chiave di volta della stagione precedente. La società degli anni Ottanta è quella della transizione post-industriale e post-fordista, con la progressiva diminuzione del numero di addetti alle attività industriali, il notevole sviluppo delle attività terziarie o di servizio e l’affermarsi di un modello produttivo all’insegna della flessibilità del lavoro. Si affermano compiutamente le politiche neoliberiste, emerse già dalla crisi degli anni Settanta. I paradigmi liberisti di concorrenza e libero mercato limitano lo spazio dell’intervento pubblico. Inizia una nuova epoca sfociata nella globalizzazione dei mercati. Con il crollo del muro di Berlino (1989), la fine della guerra fredda e della divisione del mondo in due blocchi, il settore economico-finanziario ha preso il sopravvento sulla dimensione politica.
Con la crisi e la fine del Pci, tra anni Ottanta e Novanta, si palesarono, sempre più nitidamente, una subalternità e un conformismo culturale della sinistra rispetto alle politiche economiche dominanti o, quantomeno, la mancanza di una sufficiente circolazione di idee a livello regionale e locale, mentre nel paese il liberismo surclassava l’idea di programmazione, accantonata come un ferro vecchio. Ancora a metà degli anni Novanta, tuttavia, le caratteristiche innovative del laboratorio emiliano-romagnolo venivano confermate dal fatto che fu proprio in questa regione a nascere, nell’ambito del centro-sinistra, l’esperienza dell’Ulivo”.
“Se è vero che negli anni Ottanta, la crisi del «modello emiliano» si manifestò in primo luogo all’incrocio tra la dimensione istituzionale e quella sociale, con l’incrinatura del nesso partecipazione-associazionismo-partiti-istituzioni, il suo rilancio – o, se si vuole, la nascita di un nuovo riformismo emiliano-romagnolo – potrà avvenire proprio sul terreno dei rapporti tra Regione, realtà locali e associazionismo, ma difficilmente sarà realizzabile senza un nuovo protagonismo dei partiti, a cominciare dal Partito democratico, che dovrà mettere in campo nuove strategie di insediamento sul territorio e di dialogo con la società, a partire dalle sue articolazioni di prossimità: i circoli. Un partito ha senso se al suo interno si discute e ci si confronta a tutti i livelli. Le primarie sono utili per incrementare la partecipazione, ma non bastano. Bisogna tornare a riflettere sulla “visione del mondo” che sta alla base delle proprie scelte politiche“.
Paolo Zaghini




























